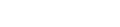ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
10/17/2024 | Press release | Distributed by Public on 10/17/2024 04:40
Netanyahu tra tattiche e strategia: il futuro di Israele nel conflitto mediorientale
Il conflitto israelo-palestinese (da cui occorre partire, nonostante l'ampliamento del confronto e la volontà di Netanyahu di rendere secondario tale aspetto) suscita reazioni che oscillano tra banalità ed emotività . Gli appelli europei a perseguire la via diplomatica e la moderazione appaiono inversamente proporzionali alla capacità di avere un impatto mentre piazze e opinioni pubbliche sono animate da sentimenti viscerali. Diventa importante ragionare sulla complessità di questioni che si intrecciano in un quadro magmatico che include la politica interna in Israele ed in America e la combinazione dei tasselli di quella che Papa Francesco dieci anni fa definì la guerra mondiale a pezzi. Un'immagine che allora poteva sembrare eccessiva, ma oggi descrive una realtà: quella delle correlazioni sempre più strette tra i grandi teatri di crisi. La guerra di aggressione russa all'Ucraina, i focolai di conflitto nel Medio Oriente e le aree di tensione in Asia orientale si intrecciano. In questo contesto, aggiungendo spessore alla complessità, occorre considerare i protagonisti: Israele (e ancora di meno l'ebraismo) non è Netanyahu, la Palestina non è Hamas, l'Iran non è il regime degli Ayatollah, il Libano non è Hezbollah. È necessario dirlo per superare le visioni manichee.
Netanyahu, premier longevo ma senza strategia?
Emerge un protagonista: Benjamin (Bibi) Netanyahu. Il Primo Ministro israeliano è abile e scaltro, ama la storia (disquisisce con competenza sugli imperatori romani) e la geografia (comprende l'importanza di illustrare le minacce utilizzando mappe geografiche), ma sembra mancare di una visione strategica. La sua strategia appare basata su una serie di azioni tattiche, che comunque lo hanno reso il Primo Ministro con il primato di permanenza al potere a Gerusalemme (superando il mitico Ben Gurion). Adesso, stretto tra vicende giudiziarie di bassa lega che ne mettono a repentaglio la libertà (in Israele Presidenti e Primi Ministri hanno sperimentato il carcere) ed un tornante esistenziale per la sopravvivenza del paese, egli rilancia con le scommesse ardite, ma si tratta di visione strategica? Bibi è sempre stato cauto (naturalmente nel contesto di parametri israeliani), ma - come ha dichiarato all'Assemblea Generale dell'Onu poche settimane fa - "enough is enough" ("quando è troppo è troppo"). Nel suo discorso ha parlato di sette fronti su cui Israele è contemporaneamente impegnato: 1. Gaza, con Hamas. 2. Libano, con Hezbollah. 3. Yemen, con gli Houthi. 4. Siria, con la presenza iraniana. 5. Iraq, con le milizie sciite. 6. Cisgiordania, con il ruolo di Hamas. 7. Iran, col regime di Khamenei. In tal modo propone una visione nella quale un elemento collega ed alimenta tutti questi fronti di minaccia: la rivoluzione messianica innescata da Teheran. Da sempre questo è stato presentato da Netanyahu come l'avversario principale, ancora più temibile nella prospettiva del possesso dell'arma atomica. Un nemico che intende eliminare l'esistenza stessa dello Stato di Israele, "un cancro da estirpare" come ha detto la Guida Suprema Khamenei. Un linguaggio simile viene usato dagli Hezbollah e la storia insegna a non sottovalutare il passaggio dalle parole ai fatti. Inoltre esiste più che un sospetto che il pogrom del sette ottobre sia stato pianificato da Hamas col sostegno di Hezbollah e che adesso questi avessero piani per un'operazione di larga scala contro il territorio israeliano.
Una partita su più livelli
Quindi Netanyahu sembra pensare ad un disegno estremamente ambizioso, che potrebbe includere l'eliminazione (o quasi) delle minacce di Hamas e Hezbollah e una forte riduzione della capacità militare iraniana con la possibilità di una caduta del regime.
Tra i tanti magmatici intrecci, c'è quello di tre livelli tra i quali Netanyahu si muove agilmente:
- I giochi di potere globale. Superate le ambiguità del suo lungo rapporto con Putin, si presenta come il paladino dell'Occidente mentre Iran, Russia e Corea del Nord (con la Cina nell'ombra) saldano la loro azione (anche con reciproci favori nella disinformazione sui social). Il prossimo vertice dei BRICS a Kazan sarà rilevante ma non determinante, le determinazioni del Consiglio Europeo spuntate senza il concorso dell'attore che conta di più: gli Stati Uniti per adesso privi di una guida;
- Le conflittualità regionali. Israele viene descritta come la "villa nella giungla", un'isola di democrazia e benessere in un contesto dove vige la legge del più forte e Netanyahu agisce con crescente spavalderia nella regione;
- Le dinamiche di politica interna. Mr. Security sembra tornato tale con i successi delle operazioni contro Hezbollah avendo fatto dimenticare il clamoroso disastro del sette ottobre e vuole ottenere così dividendi sul piano della politica interna, quello dove è più debole e rischia di più.
Intanto il teatro, comunque mutevole, del conflitto è passato dalle macerie e tunnel di Gaza, dove i successi sono stati limitati dalla necessità di salvaguardare gli ostaggi, al Libano e alle incursioni in Iran. Questo ha comportato un recupero di popolarità per Netanyahu: vanno ricordate le grandi manifestazioni di piazza contro le sue scelte di politica giudiziaria e poi quelle per affermare la priorità della vita degli ostaggi. Numerosi esponenti in pensione degli apparati di sicurezza (persone di grande autorevolezza nel sistema) hanno aspramente criticato Netanyahu, ma le operazioni mirate di intelligence condotte da Israele in Libano passeranno alla storia e riscuotono consenso. Anche intellettuali di sinistra molto anti-Netanyahu hanno applaudito agli attacchi mirati contro Hezbollah: Fania Oz, la figlia del grande romanziere Amos Oz, dissente fortemente dalla posizione del governo rispetto a Gaza ed esige le dimissioni di Netanyahu, ma si è detta favorevole all'eliminazione di Nasrallah. La reputazione degli apparati di sicurezza è a livelli stellari dopo l'inspiegabile fallimento del 7 ottobre. Sono elementi dei quali occorre essere consapevoli, ricordando la realtà di una regione dove la guerra è un fatto della vita che è del tutto estraneo al nostro orizzonte psicologico.
Peraltro, non è solo questione di Netanyahu, che non può essere il comodo capro espiatorio o demiurgo di tutto. Proprio perché Israele è più grande di lui dobbiamo tener conto delle esigenze da tutti condivise di garanzie di sicurezza. Esse vennero offerte dalla comunità internazionale con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701, che però si è tollerato venisse disattesa pretendendone il rispetto dei simulacri ma non dei contenuti.
Tre motivi spiegano l'apertura del nuovo fronte:
- La politica interna, con le critiche da destra a Netanyahu di non fare nulla mentre da un anno oltre 60.000 israeliani che vivono nel nord hanno abbandonato le loro case nel timore di attacchi terroristici.
- La finestra di opportunità prima delle elezioni americane (Harris adesso è immobilizzata, Trump è imprevedibile), tenendo conto del fatto che gli USA sono l'unico attore internazionale ad avere un'influenza effettiva (ma non illimitata) su Israele, e di conseguenza anche sulle altre parti del conflitto in virtù del peso delle forniture militari concesse a Gerusalemme.
-
La gestione militare: dopo novembre il sud del Libano diventa un terreno nel quale è più difficile manovrare.
Le capacità di Hezbollah sembrano ormai ridotte, può essere temibile la reazione iraniana se il regime si dovesse trovare con le spalle al muro: il grande rischio in un futuro ormai prossimo potrebbe essere l'uso disperato dell'arma nucleare (adesso non c'è, ma recentemente Blinken ha dichiarato che in alcune settimane l'Iran potrebbe produrre l'uranio arricchito necessario).
Ho sempre sostenuto che Israele ed Hezbollah/Iran avessero lo stesso interesse a gestire prima la necessaria escalation per conservare la credibilità della propria deterrenza (concetto che da noi deve essere recuperato mentre in quella regione è un fattore di sopravvivenza) e poi la de-escalation (per evitare di giungere al punto di non ritorno di una guerra totale che nessuno dovrebbe volere). Stavolta Netanyahu potrebbe non avere più interesse a disinnescare la situazione. Egli intende recuperare la piena sovranità sul nord di Israele e chiudere la partita in una storica prospettiva di rilancio nel rapporto con le monarchie del Golfo.
Cosa può succedere?
La storia si è messa a correre ed è determinata dai fatti sul terreno. I rischi sono enormi, ma lo sono anche le prospettive di risultati storici. È possibile che si rimetta in moto il processo favorito da Washington (in continuità tra Trump e Biden) di normalizzazione tra Israele e paesi del Golfo, avendo l'Arabia Saudita come premio finale. È un processo temuto dall'Iran (non a caso si è voluto colpirlo il 7 ottobre) e con implicazioni geopolitiche globali importanti anche per l'Italia. Si pensi al potenziale dell'India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) che creerebbe una rete di infrastrutture tra l'India e l'Europa (con possibili terminali nei nostri porti), attraversando la penisola arabica e Israele.
Esistono quindi prospettive per arrivare a quello che Peres chiamava l'obiettivo di una start-up region, ma Netanyahu non sembra considerare un ruolo per il popolo palestinese. Le violenze degli estremisti israeliani contro palestinesi anche inermi in Cisgiordania generano odio. Questo può riaccendere all'infinito spirali di terrore. Qualsiasi soluzione - per la necessaria sicurezza di Israele, per lo sviluppo pacifico della regione e per gli interessi globali dell'Occidente - dovrà passare per un accordo tra Gerusalemme e le Monarchie del Golfo, ma anche includere una realistica soluzione della questione palestinese.